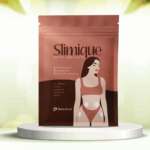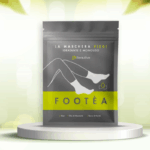Il tema del consumo moderato di alcolici è tra i più controversi nella salute pubblica e nella società contemporanea. Da decenni, si alternano ondate di dichiarazioni contrastanti: da una parte l’immagine della convivialità mediterranea, del bicchiere di vino a tavola come toccasana e simbolo di qualità della vita; dall’altra la posizione rigorosa delle grandi organizzazioni sanitarie internazionali, che sottolineano i rischi anche in caso di basse dosi. Nel mezzo, nuove ricerche, aggiornamenti epidemiologici, e dubbi costanti su quale sia davvero l’impatto sulla salute di un’abitudine così radicata e socialmente accettata.
Miti popolari e realtà scientifica
L’idea che bere alcolici moderatamente non solo non sia dannoso, ma possa persino portare benefici alla salute, è largamente diffusa. Secondo recenti indagini, una fetta consistente di popolazione – supportata anche da una parte del mondo medico – ritiene che, in particolare vino rosso e, più recentemente, birra, siano in grado di proteggere contro le malattie cardiovascolari. Questa percezione affonda le radici in studi degli anni Novanta, che osservarono una minore incidenza di infarti nei paesi dove il consumo di vino era abituale, rispetto ad altre realtà. Si parlò così di “paradosso francese” e di possibili proprietà benefiche degli antiossidanti contenuti nelle bevande fermentate.
Tuttavia, la scienza moderna invita a leggere questi dati con cautela. Le principali organizzazioni sanitarie, inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), dichiarano senza ambiguità che nessun livello di consumo di alcol è privo di rischio, nemmeno quello che tipicamente viene definito moderato. L’alcol è classificato cancerogeno per l’uomo dal 1988, con prove sempre più solide di una chiara correlazione tra il consumo, a qualsiasi livello, e l’insorgere di diversi tipi di tumori, in particolare quelli di bocca, gola, esofago, fegato e seno.
I dati sulla moderazione: benefici o rischi?
Le ricerche disponibili offrono un quadro complesso. Alcuni studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra consumo moderato (in genere definito come uno o massimo due bicchieri al giorno per l’uomo, uno per la donna) e una minore incidenza di alcune malattie cardiovascolari, rispetto agli astemi o ai forti bevitori. Alcuni metanalisi, tra cui quella coordinata dall’American Cancer Society su oltre 500.000 adulti, hanno osservato una riduzione della mortalità globale nei consumatori moderati rispetto agli astinenti, con una diminuzione particolarmente evidente tra gli uomini, stimata intorno al 25%.
Questi dati, però, sono pesantemente criticati per possibili distorsioni metodologiche. Molti degli studi che riscontrano benefici includono nei gruppi di “astemi” anche ex-bevitori che hanno smesso di bere per motivi di salute; ciò porta a sovrastimare i rischi dell’astinenza e a sottovalutare gli effetti dannosi dell’alcol. Quando si corregge questa impostazione e si confrontano i bevitori moderati solo con chi non ha mai bevuto nella vita, i vantaggi in termini di longevità e salute cardiaca svaniscono o si riducono drasticamente.
Le conclusioni degli studi più robusti, comprese le analisi pubblicate sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs e riassunte dagli esperti del Canadian Institute for Substance Use Research, sono estremamente chiare: la visione dell’alcol come un elisir di lunga vita non trova conferma scientifica. Nessuno degli organi sanitari di riferimento ha mai potuto fissare una soglia di assunzione raccomandata o “sicura”. In altre parole, non esiste alcun livello di assunzione di alcol valutato come innocuo o benefico per la popolazione generale.
Alcol e tumori: l’aspetto più sottovalutato
Uno degli aspetti più ignorati dai cultori della moderazione è quello relativo alla cancerogenicità delle bevande alcoliche. L’alcol etilico, quale che sia la forma con cui viene assunto – vino, birra o superalcolici – è riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio evitabili per numerose forme tumorali. Più di recente, sono stati pubblicati studi che mostrano un aumento del rischio già a livelli di consumo considerati bassi o moderati, in particolare per quanto riguarda il carcinoma mammario nelle donne e i tumori del tratto digestivo.
Questo dato appare spesso in contrapposizione rispetto all’enfasi sui possibili effetti protettivi cardiovascolari. In realtà, è proprio la valutazione d’insieme a suggerire cautela: anche ammesso che una minima riduzione del rischio di infarto si possa osservare in alcuni soggetti, l’aumento del rischio di tumori o di altre malattie croniche può annullare o superare il beneficio cardiovascolare.
Effetti su altri organi e cervello
Oltre ai tumori, il consumo di alcol, anche se moderato, può influire su molte altre condizioni cliniche. Recenti ricerche mostrano che consumare più di due unità di alcol al giorno può essere associato a difficoltà cognitive e a un aumento del rischio di demenza, anche se per dosi estremamente ridotte restano dei possibili effetti protettivi, un’ipotesi che necessita però di ulteriori conferme e riguarda solo una ristretta fetta della popolazione.
La bevanda “meno dannosa”: birra o vino?
L’attenzione della ricerca e dell’opinione pubblica si concentra spesso sulla domanda: esiste una bevanda alcolica più sicura o “meno dannosa” delle altre? Negli ultimi anni, i riflettori sono stati puntati in particolare sul rapporto tra vino rosso e salute, ma anche la birra, specie quella artigianale o a bassa gradazione, ha iniziato a essere oggetto di studi specifici. Uno degli ultimi report internazionali, pubblicato su Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases e coordinato dai ricercatori italiani del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed, suggerisce che la birra, assunta con moderazione (fino a una lattina al giorno), può essere affiancata al vino in termini di effetti favorevoli sul sistema cardiovascolare e sul metabolismo.
Va sottolineato, tuttavia, che queste conclusioni si riferiscono a popolazioni senza fattori di rischio particolari, con stili di vita complessivamente sani e in contesti culturali specifici. È importante rimarcare che il beneficio ipotizzato non significa assenza di rischi oncologici o di altre complicanze. Il consenso scientifico attuale è che le sostanze potenzialmente “protettive” presenti nella birra o nel vino (come polifenoli, flavonoidi, vitamine) si possono assumere con una dieta ricca, varia e priva di alcol, ad esempio consumando frutta, verdura, cereali integrali e bevande analcoliche ricche di antiossidanti.
- Il vino rosso contiene polifenoli come il resveratrolo e ha una reputazione consolidata nella cultura popolare per un possibile effetto cardioprotettivo.
- La birra, specie quella non filtrata, apporta vitamine del gruppo B e alcune sostanze antiossidanti; recenti dati la equiparano al vino in termini di eventuali effetti favorevoli, sempre quando assunta con estrema moderazione.
- I superalcolici presentano una concentrazione di etanolo più elevata e non hanno dimostrato vantaggi particolari rispetto alle altre bevande.
Alla luce delle conoscenze disponibili – e dei pareri degli organismi di salute pubblica – si può affermare che non esiste una bevanda alcolica oggettivamente sicura dal punto di vista scientifico. Tuttavia, considerando dosi molto moderate, una birra chiara a bassa gradazione o un bicchiere di vino rosso possono rappresentare, per una persona sana adulta, l’opzione meno dannosa rispetto a superalcolici o consumi più elevati e frequenti.
Conclusioni pratiche e raccomandazioni
L’attuale consenso scientifico invita a evitare qualsiasi consumo di alcolici per tutelare la propria salute, soprattutto se si hanno altre abitudini di vita potenzialmente rischiose, predisposizione famigliare a tumori o malattie cardiovascolari, o si assume già regolarmente farmaci. Per chi sceglie comunque di bere, è essenziale non superare i limiti di una-due unità al giorno, preferendo sempre i pasti e monitorando il proprio stato di salute nel tempo.
Per chi soffre di patologie acute o croniche, chi è in gravidanza, alla guida di veicoli o assume farmaci che interagiscono con il metabolismo dell’alcol, il consumo va evitato del tutto. Ricordando che, nell’ottica della prevenzione oncologica, la soglia protettiva reale è lo zero.
In definitiva, il famoso bicchiere di vino rosso o la birra chiara, assunti saltuariamente e in contesti di convivialità, possono essere la scelta meno dannosa per chi non vuole rinunciare affatto al piacere dell’alcol, ma è essenziale sfatare l’idea di una bevanda realmente “sana” o innocua. La scienza indica che la tutela della salute si accompagna più facilmente all’astensione o a un consumo estremamente consapevole e limitato.